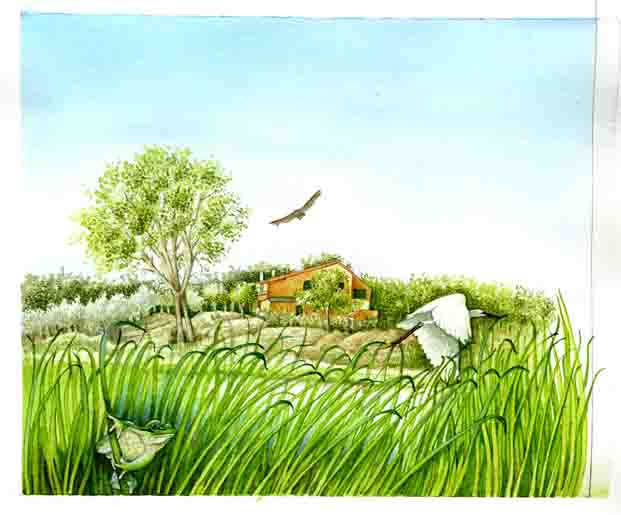Storia
Fano fu un centro piceno, come testimoniano
ritrovamenti sporadici avvenuti in città e gli scavi di Montegiove e
Roncosambaccio[6].
Fu poi un importante centro romano, conosciuto
come Fanum Fortunae,
nome che rimanda al "Tempio della Fortuna",
probabilmente eretto a testimonianza della battaglia
del Metauro: era l'anno 207
a.C. e
lelegioni
romane sbaragliarono
l'esercito del generale cartaginese Asdrubale,
uccidendone il condottiero che, dopo aver varcato le Alpi con
gli elefanti
da guerra, intendeva ricongiungersi al
fratello Annibale.
La città ebbe un notevole sviluppo durante il
dominio romano grazie alla sua posizione strategica sulla via che
congiungeva la valle
del Tevere alla Gallia
Cisalpina. Nel 49 a.C. Gaio
Giulio Cesare la
conquistò assieme a Pesaro, dando così inizio alla Guerra
Civile contro
l'antagonista Pompeo.
Solo successivamente Cesare
Ottaviano Augusto dota
l'insediamento di mura di cinta (ancora parzialmente visibili), elevando
l'insediamento allo stato di colonia
romana col
nome di Colonia Julia
Fanestris[7].
Alcuni secoli dopo, nel 271
d.C., si svolse nei suoi pressi la Battaglia
di Fano che
segnò la fine del tentativo degli Alemanni di
raggiungere Roma,
sconfitti dall'imperatore Aureliano.
Durante la Guerra
gotica del
VI secolo, a causa alla sua posizione nei collegamenti tra nord e sud
Italia, venne assediata e devastata dagli Ostrogoti di Vitige (538)
e poco tempo dopo ricostruita dall'esercito bizantino di Belisario e Narsete.

Palazzo della Ragione, sede del Teatro della fortuna
Successivamente entrò a far parte della Pentapoli
marittima (Rimini,
Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona) di cui era a capo. Subì
successivamente l'occupazione deiLongobardi e
dei Franchi,
fino a quando Ottone
III non
la donò a papa
Silvestro II. Nel XIII
secolo Fano
si costituì comune; nel secolo successivo fu per un breve periodo sotto
il dominio estense,
dopo di che fu dilaniata dalla lotta intestina tra due famiglie: i del
Cassero e i da Carignano.
Alla fine del XII
secolo la
città passò sotto il dominio Malatesta di Rimini,
grazie ad un complotto ordito da questi ultimi contro le due famiglie
rivali. La famiglia Malatesta rimase al potere nella città fino al 1463,
quando Sigismondo
Malatesta dovette
lasciare Fano al duca di Urbino Federico
da Montefeltro dopo
un lungo assedio,
nel corso del quale fu danneggiato l'Arco
d'Augusto, simbolo della città. La
popolazione si rifiutò di entrare a far parte del Ducato
di Urbino e
perciò divenne vicariato ecclesiastico.
Durante l'occupazione napoleonica dello Stato
Pontificio fu
saccheggiata e gravemente bombardata dall'esercito del Bonaparte.
Partecipò attivamente ai moti risorgimentali con
la creazione di governi provvisori.
Durante la prima
guerra mondiale (1915-1918)
subì numerosi bombardamenti navali austriaci ed anche nella seconda
guerra mondiale (1940-1945)
trovandosi sullaLinea
Gotica subì
numerose incursioni aeree alleate miranti alla distruzione dei suoi
ponti ferroviari e stradali e, da parte dell'esercito tedesco in
ritirata, la distruzione di quasi tutti i suoi campanili (tranne quelli
di S. Francesco di Paola e di San Marco), della torre civica, del maschio della
rocca malatestiana e del suo porto peschereccio, ritenuti dal nemico
infrastrutture sensibili[8]da
non lasciare nelle mani degli alleati
Monumenti e luoghi d'interesse

Piazza XX Settembre: Palazzo
della Ragione con
la cinquecentesca Fontana della Fortuna.

Monumento ai caduti della città di Fano.
Edifici civili
Fanum Fortunae era
sicuramente, in epoca romana, un importante centro sacro, infatti la
città mostra nel suo nome (Fanum) un chiaro riferimento ad
un'area sacra o tempio dedicato al culto della dea Fortuna.
Sin dall'80-70
a.C. è
da considerarsi certa la presenza romana in Fano. Il culmine della
presenza romana si ha nel periodo imperiale augusteo ed
infatti risalgono a quell'epoca un gran numero di monumenti.
-
Arco d'Augusto.
Da sempre simbolo della città di Fano, fu in epoca romana la
principale porta d'accesso alla Colonia
Julia Fanestris, dedotta dall'imperatore Augusto Fanum
Fortunae (tempio
dedicato alla Dea Fortuna). Costruito sul punto in cui la via
Flaminia s'innesta nel decumano massimo della città, il monumento si
data, tramite l'iscrizione del fregio, al 9
d.C.
-
Mura. La
cinta muraria difensiva cittadina, ancora ben conservata, venne
dapprima costruita dai Romani nel
IX secolo d.C., poi ampliata dai Malatesta nel
quattrocento e infine rinforzate dai sovrani pontifici nel '500.
Volute dall'imperatore Augusto, le mura romane si conservano ancora
oggi per circa i due terzi del circuito originario. La cinta si
dirige a nord-ovest dalla porta di Augusto fino a raggiungere la
quattrocentesca Rocca
Malatestiana
-
Cardo e Decumano.
Nella pianta attuale della città di Fano e ancora evidente: il decumanus
maximus (attuale via
Arco d'Augusto), prosecuzione urbana della strada consolare
Flaminia, ed il cardus
maximus ad esso
perpendicolare, rintracciabile in parte tra l'attuale Corso
Matteotti e la parallela via Nolfi. All'incontro di questi assi
stradali si troverebbe il foro.
Ai due assi stradali principali si affiancano, a distanze regolari,
decumani e cardini minori.
-
Via Flaminia.
Fu la strada voluta dal Console Flaminio, da cui prende il nome, e
costruita a partire dal 220
a.C. Congiunge
Roma a Rimini e probabilmente segue per lunghi tratti antiche strade
protostoricheumbre.
Solo i punti del tragitto più "difficili" venivano lastricati,
mentre gli altri erano brecciati. A Fano la Flaminia entrava in
città dall'Arco di Augusto e giunta in centro ripartiva per Rimini uscendo
dalla Porta della
Mandria (dietro il
monumento ai caduti).
- Bassorilievo
di San Paterniano. Raffigurante San
Paterniano, patrono e primo vescovo
della città di Fano, vissuto tra il III e il IV secolo, è stato
completamente restaurato. Si tratta di una scultura in pietra
arenariadel secolo XV che fino al
1926 si trovava murata nella casa che è posta all'angolo tra la
Piazza XX Settembre ed il Corso Matteotti, casa già dei Conti Giacobini, nobili di
Fano, patrizi di Jesi,
originari di Staffolo.
Come riporta Piercarlo Borgogelli Ottaviani in “Studia Picena”[14]
L'intervento di restauro è stato eseguito dal
restauratore Daniele Nardini. Il bassorilievo è esposto nello scalone di
accesso al Palazzo
malatestiano. La figura più nota di San Paterniano è senz'altro
quella che campeggia in posizione centrale nel trittico dei Protettori
che decora la facciata del palazzo del Podestà in piazza XX Settembre.
La sua posizione simboleggia la preminenza che al vescovo fanese fu
attribuito dal Consiglio maggiore della città rispetto agli altri due
santi patroni: Sant'Eusebio e San
Fortunato. Nell'edicola manca un altro
santo, Sant'Orso,
di cui una statua un tempo si trovava nei pressi della chiesa di
Sant'Antonio, nel trebbio cittadino. Tutti e quattro i santi protettori
di Fano comunque compaiono nelle vetrate policrome dell’abside del
Duomo.
- Palazzo
della Ragione, risalente al 1299 ma molto rimaneggiato, al punto
che nella metà del XIX secolo vi fu installato il Teatro
della Fortuna.
- Corte
Malatestiana. Il Palazzo dei Malatesta venne
eretto a partire dal XV secolo e presenta due ali, una in stile gotico e
l'altra dominata dalla cosiddetta Loggia
del Sansovino, rinascimentale.
Dal 1463, quando cadde la Signoria malatestiana e la città passò
allo Stato
Pontificio, divenne sede del
Comune.
|